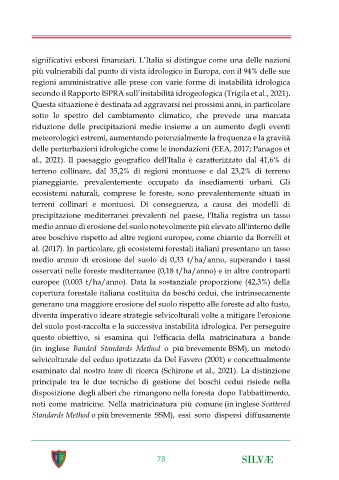Page 78 - ok rivista silvae dicembre 2024
P. 78
significativi esborsi finanziari. L’Italia si distingue come una delle nazioni
più vulnerabili dal punto di vista idrologico in Europa, con il 94% delle sue
regioni amministrative alle prese con varie forme di instabilità idrologica
secondo il Rapporto ISPRA sull’instabilità idrogeologica (Trigila et al., 2021).
Questa situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni, in particolare
sotto lo spettro del cambiamento climatico, che prevede una marcata
riduzione delle precipitazioni medie insieme a un aumento degli eventi
meteorologici estremi, aumentando potenzialmente la frequenza e la gravità
delle perturbazioni idrologiche come le inondazioni (EEA, 2017; Panagos et
al., 2021). Il paesaggio geografico dell'Italia è caratterizzato dal 41,6% di
terreno collinare, dal 35,2% di regioni montuose e dal 23,2% di terreno
pianeggiante, prevalentemente occupato da insediamenti urbani. Gli
ecosistemi naturali, comprese le foreste, sono prevalentemente situati in
terreni collinari e montuosi. Di conseguenza, a causa dei modelli di
precipitazione mediterranei prevalenti nel paese, l'Italia registra un tasso
medio annuo di erosione del suolo notevolmente più elevato all'interno delle
aree boschive rispetto ad altre regioni europee, come chiarito da Borrelli et
al. (2017). In particolare, gli ecosistemi forestali italiani presentano un tasso
medio annuo di erosione del suolo di 0,33 t/ha/anno, superando i tassi
osservati nelle foreste mediterranee (0,18 t/ha/anno) e in altre controparti
europee (0,003 t/ha/anno). Data la sostanziale proporzione (42,3%) della
copertura forestale italiana costituita da boschi cedui, che intrinsecamente
generano una maggiore erosione del suolo rispetto alle foreste ad alto fusto,
diventa imperativo ideare strategie selvicolturali volte a mitigare l'erosione
del suolo post-raccolta e la successiva instabilità idrologica. Per perseguire
questo obiettivo, si esamina qui l'efficacia della matricinatura a bande
(in inglese Banded Standards Method o più brevemente BSM), un metodo
selvicolturale del ceduo ipotizzato da Del Favero (2001) e concettualmente
esaminato dal nostro team di ricerca (Schirone et al., 2021). La distinzione
principale tra le due tecniche di gestione dei boschi cedui risiede nella
disposizione degli alberi che rimangono nella foresta dopo l'abbattimento,
noti come matricine. Nella matricinatura più comune (in inglese Scattered
Standards Method o più brevemente SSM), essi sono dispersi diffusamente
78