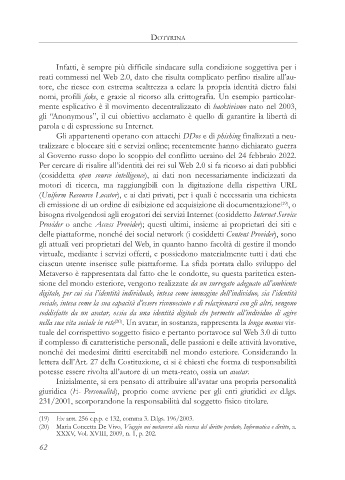Page 64 - Rassegna 2023-4
P. 64
DOTTRINA
Infatti, è sempre più difficile sindacare sulla condizione soggettiva per i
reati commessi nel Web 2.0, dato che risulta complicato perfino risalire all’au-
tore, che riesce con estrema scaltrezza a celare la propria identità dietro falsi
nomi, profili fake, e grazie al ricorso alla crittografia. Un esempio particolar-
mente esplicativo è il movimento decentralizzato di hacktivismo nato nel 2003,
gli “Anonymous”, il cui obiettivo acclamato è quello di garantire la libertà di
parola e di espressione su Internet.
Gli appartenenti operano con attacchi DDos e di phishing finalizzati a neu-
tralizzare e bloccare siti e servizi online; recentemente hanno dichiarato guerra
al Governo russo dopo lo scoppio del conflitto ucraino del 24 febbraio 2022.
Per cercare di risalire all’identità dei rei sul Web 2.0 si fa ricorso ai dati pubblici
(cosiddetta open source intelligence), ai dati non necessariamente indicizzati da
motori di ricerca, ma raggiungibili con la digitazione della rispettiva URL
(Uniform Resource Locator), e ai dati privati, per i quali è necessaria una richiesta
di emissione di un ordine di esibizione ed acquisizione di documentazione , o
(19)
bisogna rivolgendosi agli erogatori dei servizi Internet (cosiddetto Internet Service
Provider o anche Access Provider); questi ultimi, insieme ai proprietari dei siti e
delle piattaforme, nonché dei social network (i cosiddetti Content Provider), sono
gli attuali veri proprietari del Web, in quanto hanno facoltà di gestire il mondo
virtuale, mediante i servizi offerti, e possiedono materialmente tutti i dati che
ciascun utente inserisce sulle piattaforme. La sfida portata dallo sviluppo del
Metaverso è rappresentata dal fatto che le condotte, su questa paritetica esten-
sione del mondo esteriore, vengono realizzate da un surrogato adeguato all’ambiente
digitale, per cui sia l’identità individuale, intesa come immagine dell’individuo, sia l’identità
sociale, intesa come la sua capacità d’essere riconosciuto e di relazionarsi con gli altri, vengono
soddisfatte da un avatar, ossia da una identità digitale che permette all’individuo di agire
nella sua vita sociale in rete . Un avatar, in sostanza, rappresenta la longa manus vir-
(20)
tuale del corrispettivo soggetto fisico e pertanto portavoce sul Web 3.0 di tutto
il complesso di caratteristiche personali, delle passioni e delle attività lavorative,
nonché dei medesimi diritti esercitabili nel mondo esteriore. Considerando la
lettera dell’Art. 27 della Costituzione, ci si è chiesti che forma di responsabilità
potesse essere rivolta all’autore di un meta-reato, ossia un avatar.
Inizialmente, si era pensato di attribuire all’avatar una propria personalità
giuridica (E- Personalità), proprio come avviene per gli enti giuridici ex d.lgs.
231/2001, scorporandone la responsabilità dal soggetto fisico titolare.
(19) Ex artt. 256 c.p.p. e 132, comma 3. D.lgs. 196/2003.
(20) Maria Concetta De Vivo, Viaggio nei metaversi alla ricerca del diritto perduto, Informatica e diritto, a.
XXXV, Vol. XVIII, 2009, n. 1, p. 202.
62