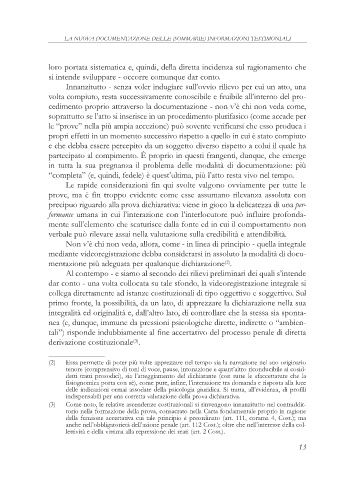Page 15 - Rassegna 2023-2
P. 15
LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI
loro portata sistematica e, quindi, della diretta incidenza sul ragionamento che
si intende sviluppare - occorre comunque dar conto.
Innanzitutto - senza voler indugiare sull’ovvio rilievo per cui un atto, una
volta compiuto, resta successivamente conoscibile e fruibile all’interno del pro-
cedimento proprio attraverso la documentazione - non v’è chi non veda come,
soprattutto se l’atto si inserisce in un procedimento plurifasico (come accade per
le “prove” nella più ampia accezione) può sovente verificarsi che esso produca i
propri effetti in un momento successivo rispetto a quello in cui è stato compiuto
e che debba essere percepito da un soggetto diverso rispetto a colui il quale ha
partecipato al compimento. È proprio in questi frangenti, dunque, che emerge
in tutta la sua pregnanza il problema delle modalità di documentazione: più
“completa” (e, quindi, fedele) è quest’ultima, più l’atto resta vivo nel tempo.
Le rapide considerazioni fin qui svolte valgono ovviamente per tutte le
prove, ma è fin troppo evidente come esse assumano rilevanza assoluta con
precipuo riguardo alla prova dichiarativa: viene in gioco la delicatezza di una per-
formance umana in cui l’interazione con l’interlocutore può influire profonda-
mente sull’elemento che scaturisce dalla fonte ed in cui il comportamento non
verbale può rilevare assai nella valutazione sulla credibilità e attendibilità.
Non v’è chi non veda, allora, come - in linea di principio - quella integrale
mediante videoregistrazione debba considerarsi in assoluto la modalità di docu-
mentazione più adeguata per qualunque dichiarazione .
(2)
Al contempo - e siamo al secondo dei rilievi preliminari dei quali s’intende
dar conto - una volta collocata su tale sfondo, la videoregistrazione integrale si
collega direttamente ad istanze costituzionali di tipo oggettivo e soggettivo. Sul
primo fronte, la possibilità, da un lato, di apprezzare la dichiarazione nella sua
integralità ed originalità e, dall’altro lato, di controllare che la stessa sia sponta-
nea (e, dunque, immune da pressioni psicologiche dirette, indirette o “ambien-
tali”) risponde indubbiamente al fine accertativo del processo penale di diretta
derivazione costituzionale .
(3)
(2) Essa permette di poter più volte apprezzare nel tempo sia la narrazione nel suo originario
tenore (comprensivo di toni di voce, pause, intonazione e quant’altro riconducibile ai cosid-
detti tratti prosodici), sia l’atteggiamento del dichiarante (con tutte le sfaccettature che la
fisiognomica porta con sé), come pure, infine, l’interazione tra domanda e risposta alla luce
delle indicazioni ormai assodate della psicologia giuridica. Si tratta, all’evidenza, di profili
indispensabili per una corretta valutazione della prova dichiarativa.
(3) Come noto, le relative ascendenze costituzionali si rinvengono innanzitutto nel contraddit-
torio nella formazione della prova, consacrato nella Carta fondamentale proprio in ragione
della funzione accertativa cui tale principio è preordinato (art. 111, comma 4, Cost.); ma
anche nell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.); oltre che nell’interesse della col-
lettività e della vittima alla repressione dei reati (art. 2 Cost.).
13