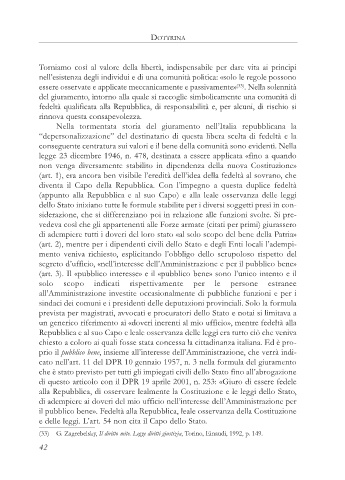Page 44 - Rassegna 2023-1
P. 44
DOTTRINA
Torniamo così al valore della libertà, indispensabile per dare vita ai principi
nell’esistenza degli individui e di una comunità politica: «solo le regole possono
essere osservate e applicate meccanicamente e passivamente» . Nella solennità
(33)
del giuramento, intorno alla quale si raccoglie simbolicamente una comunità di
fedeltà qualificata alla Repubblica, di responsabilità e, per alcuni, di rischio si
rinnova questa consapevolezza.
Nella tormentata storia del giuramento nell’Italia repubblicana la
“depersonalizzazione” del destinatario di questa libera scelta di fedeltà e la
conseguente centratura sui valori e il bene della comunità sono evidenti. Nella
legge 23 dicembre 1946, n. 478, destinata a essere applicata «fino a quando
non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione»
(art. 1), era ancora ben visibile l’eredità dell’idea della fedeltà al sovrano, che
diventa il Capo della Repubblica. Con l’impegno a questa duplice fedeltà
(appunto alla Repubblica e al suo Capo) e alla leale osservanza delle leggi
dello Stato iniziano tutte le formule stabilite per i diversi soggetti presi in con-
siderazione, che si differenziano poi in relazione alle funzioni svolte. Si pre-
vedeva così che gli appartenenti alle Forze armate (citati per primi) giurassero
di adempiere tutti i doveri del loro stato «al solo scopo del bene della Patria»
(art. 2), mentre per i dipendenti civili dello Stato e degli Enti locali l’adempi-
mento veniva richiesto, esplicitando l’obbligo dello scrupoloso rispetto del
segreto d’ufficio, «nell’interesse dell’Amministrazione e per il pubblico bene»
(art. 3). Il «pubblico interesse» e il «pubblico bene» sono l’unico intento e il
solo scopo indicati rispettivamente per le persone estranee
all’Amministrazione investite occasionalmente di pubbliche funzioni e per i
sindaci dei comuni e i presidenti delle deputazioni provinciali. Solo la formula
prevista per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato e notai si limitava a
un generico riferimento ai «doveri inerenti al mio ufficio», mentre fedeltà alla
Repubblica e al suo Capo e leale osservanza delle leggi era tutto ciò che veniva
chiesto a coloro ai quali fosse stata concessa la cittadinanza italiana. Ed è pro-
prio il pubblico bene, insieme all’interesse dell’Amministrazione, che verrà indi-
cato nell’art. 11 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 nella formula del giuramento
che è stato previsto per tutti gli impiegati civili dello Stato fino all’abrogazione
di questo articolo con il DPR 19 aprile 2001, n. 253: «Giuro di essere fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato,
di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per
il pubblico bene». Fedeltà alla Repubblica, leale osservanza della Costituzione
e delle leggi. L’art. 54 non cita il Capo dello Stato.
(33) G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, p. 149.
42