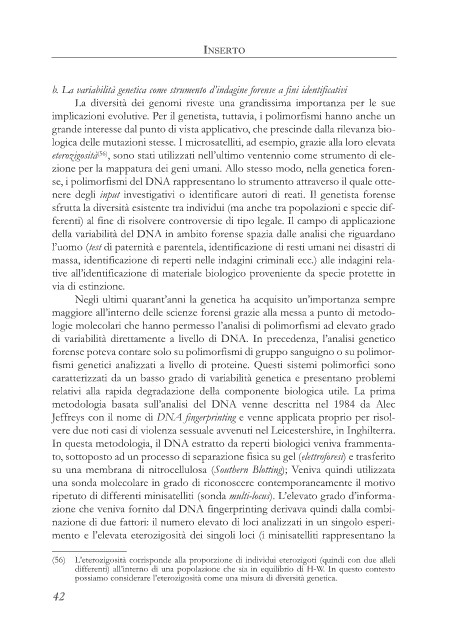Page 44 - Layout 2
P. 44
INSERTO
b. La variabilità genetica come strumento d’indagine forense a fini identificativi
La diversità dei genomi riveste una grandissima importanza per le sue
implicazioni evolutive. Per il genetista, tuttavia, i polimorfismi hanno anche un
grande interesse dal punto di vista applicativo, che prescinde dalla rilevanza bio-
logica delle mutazioni stesse. I microsatelliti, ad esempio, grazie alla loro elevata
eterozigosità , sono stati utilizzati nell’ultimo ventennio come strumento di ele-
(56)
zione per la mappatura dei geni umani. Allo stesso modo, nella genetica foren-
se, i polimorfismi del DNA rappresentano lo strumento attraverso il quale otte-
nere degli input investigativi o identificare autori di reati. Il genetista forense
sfrutta la diversità esistente tra individui (ma anche tra popolazioni e specie dif-
ferenti) al fine di risolvere controversie di tipo legale. Il campo di applicazione
della variabilità del DNA in ambito forense spazia dalle analisi che riguardano
l’uomo (test di paternità e parentela, identificazione di resti umani nei disastri di
massa, identificazione di reperti nelle indagini criminali ecc.) alle indagini rela-
tive all’identificazione di materiale biologico proveniente da specie protette in
via di estinzione.
Negli ultimi quarant’anni la genetica ha acquisito un’importanza sempre
maggiore all’interno delle scienze forensi grazie alla messa a punto di metodo-
logie molecolari che hanno permesso l’analisi di polimorfismi ad elevato grado
di variabilità direttamente a livello di DNA. In precedenza, l’analisi genetico
forense poteva contare solo su polimorfismi di gruppo sanguigno o su polimor-
fismi genetici analizzati a livello di proteine. Questi sistemi polimorfici sono
caratterizzati da un basso grado di variabilità genetica e presentano problemi
relativi alla rapida degradazione della componente biologica utile. La prima
metodologia basata sull’analisi del DNA venne descritta nel 1984 da Alec
Jeffreys con il nome di DNA fingerprinting e venne applicata proprio per risol-
vere due noti casi di violenza sessuale avvenuti nel Leicestershire, in Inghilterra.
In questa metodologia, il DNA estratto da reperti biologici veniva frammenta-
to, sottoposto ad un processo di separazione fisica su gel (elettroforesi) e trasferito
su una membrana di nitrocellulosa (Southern Blotting); Veniva quindi utilizzata
una sonda molecolare in grado di riconoscere contemporaneamente il motivo
ripetuto di differenti minisatelliti (sonda multi-locus). L’elevato grado d’informa-
zione che veniva fornito dal DNA fingerprinting derivava quindi dalla combi-
nazione di due fattori: il numero elevato di loci analizzati in un singolo esperi-
mento e l’elevata eterozigosità dei singoli loci (i minisatelliti rappresentano la
(56) L’eterozigosità corrisponde alla proporzione di individui eterozigoti (quindi con due alleli
differenti) all’interno di una popolazione che sia in equilibrio di H-W. In questo contesto
possiamo considerare l’eterozigosità come una misura di diversità genetica.
42