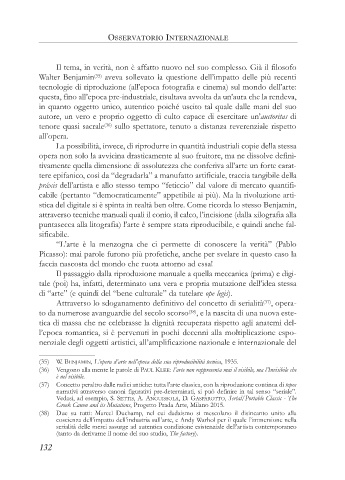Page 134 - Rassegna 2021-2
P. 134
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Il tema, in verità, non è affatto nuovo nel suo complesso. Già il filosofo
Walter Benjamin aveva sollevato la questione dell’impatto delle più recenti
(35)
tecnologie di riproduzione (all’epoca fotografia e cinema) sul mondo dell’arte:
questa, fino all’epoca pre-industriale, risultava avvolta da un’aura che la rendeva,
in quanto oggetto unico, autentico poiché uscito tal quale dalle mani del suo
autore, un vero e proprio oggetto di culto capace di esercitare un’auctoritas di
tenore quasi sacrale sullo spettatore, tenuto a distanza reverenziale rispetto
(36)
all’opera.
La possibilità, invece, di riprodurre in quantità industriali copie della stessa
opera non solo la avvicina drasticamente al suo fruitore, ma ne dissolve defini-
tivamente quella dimensione di assolutezza che conferiva all’arte un forte carat-
tere epifanico, così da “degradarla” a manufatto artificiale, traccia tangibile della
práxis dell’artista e allo stesso tempo “feticcio” dal valore di mercato quantifi-
cabile (pertanto “democraticamente” appetibile ai più). Ma la rivoluzione arti-
stica del digitale si è spinta in realtà ben oltre. Come ricorda lo stesso Benjamin,
attraverso tecniche manuali quali il conio, il calco, l’incisione (dalla xilografia alla
puntasecca alla litografia) l’arte è sempre stata riproducibile, e quindi anche fal-
sificabile.
“L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità” (Pablo
Picasso): mai parole furono più profetiche, anche per svelare in questo caso la
faccia nascosta del mondo che ruota attorno ad essa!
Il passaggio dalla riproduzione manuale a quella meccanica (prima) e digi-
tale (poi) ha, infatti, determinato una vera e propria mutazione dell’idea stessa
di “arte” (e quindi del “bene culturale” da tutelare ope legis).
Attraverso lo sdoganamento definitivo del concetto di serialità , opera-
(37)
to da numerose avanguardie del secolo scorso , e la nascita di una nuova este-
(38)
tica di massa che ne celebrasse la dignità recuperata rispetto agli anatemi del-
l’epoca romantica, si è pervenuti in pochi decenni alla moltiplicazione espo-
nenziale degli oggetti artistici, all’amplificazione nazionale e internazionale del
(35) W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1935.
(36) Vengono alla mente le parole di PAUL KLEE: l’arte non rappresenta mai il visibile, ma l’Invisibile che
è nel visibile.
(37) Concetto peraltro dalle radici antiche: tutta l’arte classica, con la riproduzione continua di topos
narrativi attraverso canoni figurativi pre-determinati, si può definire in tal senso “seriale”.
Vedasi, ad esempio, S. SETTIS, A. ANGUISSOLA, D. GASPAROTTO, Serial/Portable Classic - The
Greek Canon and its Mutations, Progetto Prada Arte, Milano 2015.
(38) Due su tutti: Marcel Duchamp, nel cui dadaismo si mescolano il disincanto unito alla
coscienza dell’impatto dell’industria sull’arte, e Andy Warhol per il quale l’immersione nella
serialità delle merci assurge ad autentica condizione esistenziale dell’artista contemporaneo
(tanto da derivarne il nome del suo studio, The factory).
132