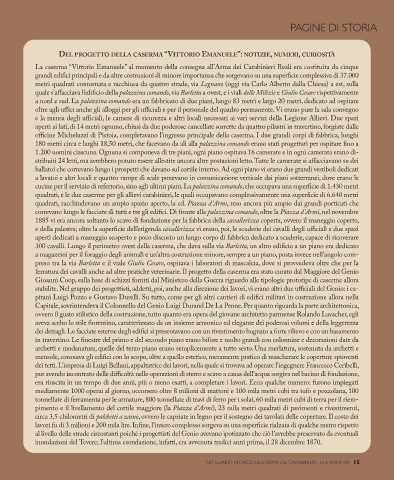Page 15 - NotiziarioStorico2022-6
P. 15
PAGINE DI STORIA
DEL PROGETTO DELLA CASERMA “VITTORIO EMANUELE”: NOTIZIE, NUMERI, CURIOSITÀ
La caserma “Vittorio Emanuele” al momento della consegna all’Arma dei Carabinieri Reali era costituita da cinque
grandi edifici principali e da altre costruzioni di minore importanza che sorgevano su una superficie complessiva di 37.000
metri quadrati contornata e racchiusa da quattro strade, via Legnano (oggi via Carlo Alberto dalla Chiesa) a est, sulla
quale s’affacciava l’edificio della palazzina comando, via Barletta a ovest, e i viali delle Milizie e Giulio Cesare rispettivamente
a nord e sud. La palazzina comando era un fabbricato di due piani, lungo 83 metri e largo 20 metri, dedicato ad ospitare
oltre agli uffici anche gli alloggi per gli ufficiali e per il personale del quadro permanente. Vi erano pure la sala convegno
e la mensa degli ufficiali, le camere di sicurezza e altri locali necessari ai vari servizi della Legione Allievi. Due spazi
aperti ai lati, di 14 metri ognuno, chiusi da due poderose cancellate sorrette da quattro pilastri in travertino, forgiate dalle
officine Micheluzzi di Pistoia, completavano l’ingresso principale della caserma. I due grandi corpi di fabbrica, lunghi
180 metri circa e larghi 18,50 metri, che facevano da ali alla palazzina comando erano stati progettati per ospitare fino a
1.200 uomini ciascuna. Ognuna si componeva di tre piani, ogni piano ospitava 16 camerate e in ogni camerata erano di-
stribuiti 24 letti, ma avrebbero potuto essere allestite ancora altre postazioni letto. Tutte le camerate si affacciavano su dei
ballatoi che correvano lungo i prospetti che davano sul cortile interno. Ad ogni piano vi erano due grandi vestiboli dedicati
a lavatoi e altri locali e quattro rampe di scale ponevano in comunicazione verticale dai piani sotterranei, dove erano le
cucine per il servizio di refettorio, sino agli ultimi piani. La palazzina comando, che occupava una superficie di 1.430 metri
quadrati, e le due caserme per gli allievi carabinieri, le quali occupavano complessivamente una superficie di 6.640 metri
quadrati, racchiudevano un ampio spazio aperto, la cd. Piazza d’Armi, reso ancora più ampio dai grandi porticati che
correvano lungo le facciate di tutti e tre gli edifici. Di fronte alla palazzina comando, oltre la Piazza d’Armi, nel novembre
1885 vi era ancora soltanto lo scavo di fondazione per la fabbrica della cavallerizza coperta, ovvero il maneggio coperto,
e della palestra; oltre la superficie dell’erigenda cavallerizza vi erano, poi, le scuderie dei cavalli degli ufficiali e due spazi
aperti dedicati a maneggio scoperto e poco discosto un lungo corpo di fabbrica dedicato a scuderie, capace di ricoverare
300 cavalli. Lungo il perimetro ovest della caserma, che dava sulla via Barletta, un altro edificio a un piano era dedicato
a magazzini per il foraggio degli animali e un’altra costruzione minore, sempre a un piano, posta invece nell’angolo com-
preso tra la via Barletta e il viale Giulio Cesare, ospitava i laboratori di mascalcia, dove si provvedeva oltre che per la
ferratura dei cavalli anche ad altre pratiche veterinarie. Il progetto della caserma era stato curato dal Maggiore del Genio
Gioanni Coop, sulla base di schizzi forniti dal Ministero della Guerra riguardo alle tipologie prototipe di caserme allora
stabilite. Nel gruppo dei progettisti, addetti, poi, anche alla direzione dei lavori, vi erano altri due ufficiali del Genio: i ca-
pitani Luigi Pozzo e Gustavo Durelli. Su tutto, come per gli altri cantieri di edifici militari in costruzione allora nella
Capitale, sovrintendeva il Colonnello del Genio Luigi Durand De La Penne. Per quanto riguarda la parte architettonica,
ovvero il gusto stilistico della costruzione, tutto quanto era opera del giovane architetto parmense Rolando Lavacher, egli
aveva scelto lo stile fiorentino, caratterizzato da un insieme armonico ed elegante dei poderosi volumi e della leggerezza
dei dettagli. Le facciate esterne degli edifici si presentavano con un rivestimento bugnato a forte rilievo e con un basamento
in travertino. Le finestre del primo e del secondo piano erano bifore e molto grandi con colonnine e decorazioni date da
archetti e modanature, quelle del terzo piano erano semplicemente a tutto sesto. Una merlatura, sostenuta da archetti e
mensole, coronava gli edifici con lo scopo, oltre a quello estetico, meramente pratico di mascherare le coperture spioventi
dei tetti. L’impresa di Luigi Belluni, appaltatrice dei lavori, nella quale si trovava ad operare l’ingegnere Francesco Ceribelli,
pur avendo incontrato delle difficoltà nelle operazioni di sterro e scavo a causa dell’acqua sorgiva nel bacino di fondazione,
era riuscita in un tempo di due anni, più o meno esatti, a completare i lavori. Ecco qualche numero: furono impiegati
mediamente 1000 operai al giorno, occorsero oltre 8 milioni di mattoni e 100 mila metri cubi tra tufo e pozzolana, 100
tonnellate di ferramenta per le armature, 800 tonnellate di travi di ferro per i solai, 60 mila metri cubi di terra per il riem-
pimento e il livellamento del cortile maggiore (la Piazza d’Armi), 23 mila metri quadrati di pavimenti e rivestimenti,
circa 3,5 chilometri di palchetti a zaino, ovvero le capriate in legno per il sostegno dei tavolati delle coperture. Il costo dei
lavori fu di 3 milioni e 200 mila lire. Infine, l’intero complesso sorgeva su una superficie rialzata di qualche metro rispetto
al livello delle strade circostanti poiché i progettisti del Genio avevano ipotizzato che ciò l’avrebbe preservato da eventuali
inondazioni del Tevere; l’ultima esondazione, infatti, era avvenuta tredici anni prima, il 28 dicembre 1870.
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 6 ANNO VII 15