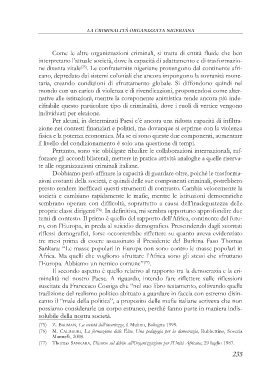Page 237 - Rassegna 2019-4
P. 237
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NIGERIANA
Come le altre organizzazioni criminali, si tratta di entità fluide che ben
interpretano l’attuale società, dove la capacità di adattamento e di trasformazio-
ne diventa vitale . Le confraternite nigeriane provengono dal continente afri-
(75)
cano, depredato dai sistemi coloniali che ancora impongono la sovranità mone-
taria, creando condizioni di sfruttamento globale. Si diffondono quindi nel
mondo con un carico di violenza e di rivendicazioni, proponendosi come alter-
native alle istituzioni, mentre la componente animistica rende ancora più inde-
cifrabile questo particolare tipo di criminalità, dove i ruoli di vertice vengono
individuati per elezione.
Per alcuni, in determinati Paesi c’è ancora una ridotta capacità di infiltra-
zione nei contesti finanziari e politici, ma dovunque si esprime con la violenza
fisica e la potenza economica. Ma se ci sono queste due componenti, aumentare
il livello del condizionamento è solo una questione di tempi.
Pertanto, sono vie obbligate ribadire le collaborazioni internazionali, raf-
forzare gli accordi bilaterali, mettere in pratica attività analoghe a quelle riserva-
te alle organizzazioni criminali italiane.
Dobbiamo però affinare la capacità di guardare oltre, poiché le trasforma-
zioni costanti della società, e quindi delle sue componenti criminali, potrebbero
presto rendere inefficaci questi strumenti di contrasto. Cambia velocemente la
società e cambiano rapidamente le mafie, mentre le istituzioni democratiche
sembrano operare con difficoltà, soprattutto a causa dell’inadeguatezza delle
proprie classi dirigenti . In definitiva, mi sembra opportuno approfondire due
(76)
temi di contesto. Il primo è quello del rapporto dell’Africa, continente del futu-
ro, con l’Europa, in preda al suicidio demografico. Prescindendo dagli scontati
riflessi demografici, forse occorrerebbe riflettere su quanto aveva evidenziato
tre mesi prima di essere assassinato il Presidente del Burkina Faso Thomas
Sankara: “Le masse popolari in Europa non sono contro le masse popolari in
Africa. Ma quelli che vogliono sfruttare l’Africa sono gli stessi che sfruttano
l’Europa. Abbiamo un nemico comune” .
(77)
Il secondo aspetto è quello relativo al rapporto tra la democrazia e la cri-
minalità nel nostro Paese. A riguardo, intendo fare riflettere sulle riflessioni
suscitate da Francesco Cossiga che “nel suo libro testamento, coltivando quella
tradizione del realismo politico abituato a guardare in faccia con estremo disin-
canto il “male della politica”, a proposito delle mafie italiane scriveva che non
possiamo considerarle un corpo estraneo, perché fanno parte in maniera indis-
solubile della nostra società.
(75) Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna 1999.
(76) M. CALIGIURI, La formazione delle Élite. Una pedagogia per la democrazia, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2008.
(77) Thomas SANKARA, Discorso sul debito all’Organizzazione per l’Unità Africana, 29 luglio 1987.
235