La montagna anche in Sardegna è da tempo interessata da un forte declino demografico che si ripercuote sul tessuto economico, sociale e ambientale.
In particolare le aree remote e montane dell’Ogliastra (Sardegna centro-orientale) si trovano ad affrontare non solo tale fragilità specifica, attualmente irrisolta, ma anche il mancato riconoscimento del loro potenziale unico in termini di peculiarità ambientali e crescita economica.
Questi territori, seppur isolati da un punto di vista sia ambientale sia economico-sociale, sono determinanti per la sicurezza alimentare, ecologica e per la salute di tutta la Sardegna come evidenziato in particolare anche dai recenti studi sulla Blue zone (Puxeddu, 2023; Soddu Pirellas et al., 2024). Oggi la consapevolezza di questo importante ruolo sta via via aumentando, ma i nuovi impulsi per una vera comprensione e un sempre più urgente soddisfacimento di tali bisogni possono produrre esempi virtuosi solo con la conservazione dei suoi eccezionali caratteri naturalistici e quindi in primis della biodiversità, di cui l’albero del castagno, con i suoi boschi e con i suoi numerosi prodotti, costituisce un esempio particolarmente significativo.
Il castagno (Castanea sativa Mill.) in Sardegna La montagna mediterranea, con le sue caratteristiche e le sue tradizioni, ha nelle foreste una componente fondamentale che la rende unica sia dal punto di vista naturalistico che conservazionistico. In questo senso la disciplina legislativa nazionale e regionale riguardante la protezione degli alberi e delle foreste, a partire da quella prevista dal Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n.3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani- e in particolare per i castagneti, da quella prevista dal Regio Decreto-Legge 18 giugno 1931, n.973 – Provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno – ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento dell’attuale quadro inventariale della risorsa che per la Sardegna, come riportato da Gasparini et al. (2022), mostra, riguardo nello specifico lo sviluppo della superficie forestale, il dato di 1.300.991 ettari (pari ad oltre il 50 % di tutta la superficie territoriale isolana).
A ben vedere però in Sardegna solo il 48% (626.140 ettari) di tutta la superficie forestale è rappresentata da “boschi alti”, ovvero capaci di realizzare una copertura superiore al 10%, con specie arboree di almeno 5 metri di altezza a maturità in situ, su oltre 5.000 metri quadrati e larghezza superiore a 20 metri (FAO, 2001).
Se infatti in Italia i boschi alti rappresentano più dell’80% della superficie forestale, d’altra parte in Sardegna le “altre terre boscate”, coincidenti in prevalenza con la macchia mediterranea e gli arbusteti, ovvero formazioni vegetali di specie arboree e arbustive con copertura e/o altezza inferiori alle soglie citate, sono estese su 674.851 ettari, rappresentando il 52% di tutta la superficie forestale inventariata.
Proprio in questo quadro le selve castanili (intese come boschi alti di castagno) in Sardegna rivestono particolare importanza giacché con la loro superficie di appena 2.240 ettari (meno dello 0,5 % di tutta la superficie forestale) svolgono un ruolo fondamentale soprattutto per la conservazione della biodiversità e per la capacità di ricadute funzionali positive anche per la conservazione delle altre foreste dell’Isola: questo in funzione del potenziale adattivo che hanno dimostrato di possedere per resistere fino ad oggi ad avversità ambientali di estrema severità, talvolta catastrofiche, quali incendi, importanti calamità atmosferiche e più di recente cambiamento climatico.
Il castagno in Ogliastra e le sue funzioni In Ogliastra (Sardegna centro-orientale) le selve castanili sono ancora meno estese rispetto al dato della superficie regionale, ma occorre evidenziare come la coltivazione del castagno abbia sempre avuto in quest’area, sin dall’antichità, una lunga tradizione in quanto considerata fondamentale sia come riserva calorica quale fonte di alimentazione sia per riscaldamento e costruzioni.

Fig. 1- Localizzazione dell’Ogliastra
Ancorché la superficie attualmente coperta da queste selve sia effettivamente ridotta (152 ettari in totale), distribuita in stazioni localizzate in media intorno agli 800 m. s.l.m., con esposizioni in prevalenza settentrionali, su pendenze medie del 30 %, suoli acidi o mediamente acidi (Typic Xerumbrepts e Typic Xerorthents) e con precipitazioni medie annue tra gli 800 ed i 1000 mm, a maggior ragione è essenziale il ruolo che questi boschi rivestono oggi per la conservazione della biodiversità.
Sono boschi da legno (20 %) e misti da legno e frutto (50%), risultando solo il 30 % i castagneti esclusivamente da frutto.

Fig. 2- Caratteristiche stazionali dei castagneti in Ogliastra
Proprio in Ogliastra queste selve, pur nella loro diversa tipologia, rivestono nell’insieme una grande importanza soprattutto perché costituiscono ecosistemi complessi capaci di fornire una molteplicità di beni e servizi (ecosistemici) a completo supporto del benessere della popolazione residente in un area da tempo in crisi demografica il cui contrasto passa dalla protezione dell'assetto idrogeologico del territorio (più volte colpito nell’ultimo secolo da eventi climatici estremi, oggi amplificati anche dal cambiamento climatico), dal miglioramento della qualità dell'aria e degli altri fattori socio-ambientali legati alla salute pubblica, dalla conservazione del paesaggio e della biodiversità vegetale e animale. Tutte queste funzioni, che risultano così mirabilmente assolte, favoriscono nel contempo l’attività turistica e ricreativa nonché le filiere produttive foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi (castagne, miele, frutti di bosco, funghi e tartufi) in grado di contribuire concretamente alla crescita del tessuto economico, sociale e ambientale dell’area e parimenti al contrasto della piaga dello spopolamento.
La conservazione della biodiversità castanicola in Ogliastra In generale tutte le attività forestali possono contribuire alla conservazione della biodiversità ivi compresa quella castanicola.
Sono però gli interventi di gestione conservativa degli habitat, di rinaturalizzazione dei sistemi forestali semplificati, di ricostituzione dei sistemi forestali interessati da avversità abiotiche e biotiche, di difesa del suolo anche a carattere estensivo, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e contro i patogeni, quelli che innanzitutto si evidenziano come maggiormente necessari.
In Ogliastra, in particolare, oltre ai sopra citati interventi si rende necessario procedere a una azione di conservazione e valorizzazione della biodiversità castanicola attraverso una serie di interventi urgenti che favoriscano la gestione colturale dei popolamenti di castagno esistenti.

Fig. 3- Castagneto e castagne d’Ogliastra
Tra questi possono venir elencati: per le selve da legno i diradamenti selettivi ed i rinfoltimenti con “selvaggioni” di provenienza locale; per le selve da frutto le potature di rimonda e le ripuliture dalla vegetazione concorrente, oggi tra l’altro sempre più meccanizzabili anche mediante l’uso di robot radiocomandati. A questi interventi devono affiancarsi specifiche azioni di conservazione e valorizzazione delle principali varietà da frutto e da legno autoctone antiche, arrivate sino a noi in particolare grazie alla loro longevità, mediante realizzazione e cura di arboreti clonali o di conservazione e di nuovi rimboschimenti, assicurando nel contempo la lotta fitosanitaria che in presenza degli effetti diretti (ad esempio stress idrico e differita maturazione dei frutti) e indiretti (maggiore virulenza dei patogeni) dovuti al cambiamento climatico si concentra in prevalenza su quella biologica e integrata. Esempi di tale lotta sono quelli contro il cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) mediante impiego di Torymus sinensis Kamijo, contro il cancro corticale (Cryphonectria parasitica Murril) mediante utilizzo di ceppi ipovirulenti e contro il mal dell’inchiostro (Phytophthora cambivora Buisman) con utilizzo di ammendanti fungicidi capaci di indurre meccanismi di resistenza da implementare con l’azione di funghi antagonisti (Trichoderma spp.).
Ma la conservazione della biodiversità castanicola si attua inoltre attraverso la difesa dei “grandi alberi”, attività quest’ultima prevista, in tutta Italia, Sardegna compresa, in particolare dalla Legge 14 gennaio 2013, n.10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e dal successivo Decreto Ministeriale (MiPAAF) 23 ottobre 2014.
Per il pregio legato a un insieme di fattori peculiari, quali l’età e le dimensioni, la forma e il portamento, la rarità botanica, l’architettura vegetale, i valori paesaggistici, ecologici, nonché storici, culturali e religiosi, numerosi individui in Sardegna sono inseriti nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali.
L’Ogliastra in particolare, tra tutte le province della Sardegna, vanta il maggior numero di grandi alberi iscritti in Elenco che non solo per i valori anzidetti, ma più propriamente per quelli biologici, ecologici e genetici, oggi si connotano quali enormi risorse di biodiversità meritevoli di protezione assoluta finalizzata alla conservazione (Giannini e Susmel, 2005; Puxeddu, 2021).
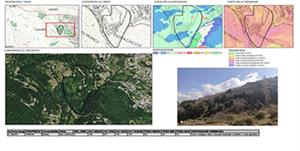
Fig. 4- Esempi di localizzazione e stima dell’estensione dei castagneti distinti per finalità da frutto o da legno
La messa a punto di metodologie cartografiche dedicate alla localizzazione e alla stima dell’estensione dei castagneti distinti per finalità produttive prevalenti (da frutto, da legno, miste), la stima delle effettive capacità produttive dei castagneti da legno, attraverso analisi spaziali e l’uso di dati inventariali e telerilevati con tecniche di telerilevamento attivo (Lidar) e passivo (da immagini satellitari multispettrali) nonché il monitoraggio, anche con l’utilizzo di droni, per la modellizzazione dello stress idrico e dello stato di salute delle singole piante (Puxeddu et al., 2021), al fine di ottimizzare eventuali interventi di soccorso e fitosanitari nei castagneti da frutto, completano i diversi interventi che si ritengono necessari per la conservazione della biodiversità castanicola in Ogliastra.

Fig. 5- Utilizzo di droni per monitorare e modellizzare lo stress idrico e lo stato di salute nei castagneti da frutto
Considerazioni conclusive È universalmente noto il principio secondo il quale “prevenire è meglio che curare”.
In senso generale, per prevenire la perdita di biodiversità occorre conoscere il più possibile le cause di questa e tutte le azioni potenzialmente capaci di determinarla.
Tenendo conto delle principali caratteristiche ambientali e strutturali dei castagneti Ogliastrini, intesi sia come boschi da frutto sia come selve da legno o a vocazione mista, nonché del loro sviluppo in termini di superfici, funzioni, servizi e redditi forniti, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, si ritiene urgente realizzare interventi gestionali, colturali e fitosanitari che favoriscano la conservazione e la valorizzazione della biodiversità ad oggi ancora presente.
Conservare e valorizzare la biodiversità castanicola esistente in Ogliastra significa anche sensibilizzare, aggiornare, e responsabilizzare, attraverso una conoscenza identificativa, scientifica e culturale i castanicoltori, che sono stati, sin dall’antichità, come si è avuto modo di esporre, i veri custodi della risorsa.
Non meno importante, per perseguire il fine suddetto, sarà il prestare attenzione al bilancio economico delle varie attività e migliorare nel contempo la visibilità di tutti i risultati raggiunti nel settore, di cui si potrà proficuamente avvantaggiare anche l’associazionismo, in quanto in tal modo maggiormente capace di attenuare le difficoltà dovute alla frammentazione aziendale in una area montana così difficile e remota come l’Ogliastra.
Bibliografia
FAO (2001) – Global Forest Resources Assessment 2000. FRA 2000. Main Report. FAO Forestry Paper 140.https://www.fao.org/forestry/fra/86624/en/.
Gasparini P., Di Cosmo L., Floris A., De Laurentis D. (2022) – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio – Metodi e Risultati della Terza Indagine. Springer, p.1-576.https://doi.org/10.1007/978-3-030-98678-0.
Giannini R., Susmel L. (2005) - Foreste, boschi e arboricoltura da legno. In: “L’Agricoltura nelle aree protette: vincoli ed opportunità”. Accademia Italiana di Agricoltura, p. 159-183.
Puxeddu M. (2021) - Giganti d’Ogliastra: grandi alberi relitti di Sardegna. L’Italia Forestale e Montana / Italian Journal of Forest and Mountain Environments, 76 (4): 197-203. https://dx.doi.org/10.4129/ifm.2021.4.03.
Puxeddu M., Cuccuru F., Fais S., Casula G., Bianchi M.G. (2021) - 3D Imaging of CRP and ultrasonic tomography to detect decay in a living adult holm oak (Quercus ilex L.) in Sardinia (Italy). Applied Sciences, 11, 1199. https://doi.org/10.3390/app11031199
Puxeddu M. (2023) - Dal leccio con ghiande dolci al pane de ispeli: un esempio di geofagia in Sardegna. Silvae.it, Rivista tecnico-scientifica ambientale dell’Arma dei Carabinieri, ISBN 2532-7828. https://www.carabinieri.it/media---comunicazione/silvae/la-rivista/home.
Soddu Pirellas A., Ballero M., Porcu S., Serra G., Sanna F., Puxeddu M. (2024) - Collaborative Monitoring of Plant Biodiversity and Research on Sweet Acorn Oaks within Paths of Knowledge and Sustainability Education. Environments 2024, 11, 59. https://doi.org/10.3390/ environments11030059.